Ritorna alla PAGINA PRECEDENTE
Le crisi aziendali oggi vengono chiamate default, e la loro analisi è utile per individuare le cause di insuccesso delle aziende. Il termine, di chiara matrice inglese, è stato ampiamente utilizzato nei numerosi casi di grandi crack aziendali in vari Paesi. I casi Cirio e Parmalat sono ormai famosi in Italia. Il termine, introdotto per le grandi aziende quotate, costituisce uno dei numerosi vocaboli che fanno parte della nuova lingua franca internazionale, simile al medioevale sabir, un misto di italiano, spagnolo ed arabo usato in tutto il Mediterraneo.
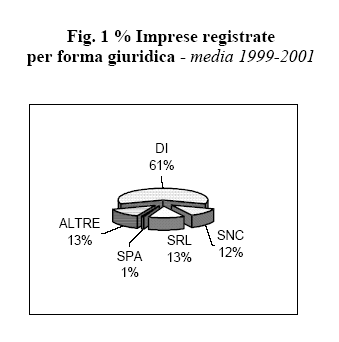
Abbiamo cercato di indagare l'andamento dei default in Calabria servendoci del recente saggio "Analisi dei fallimenti delle imprese per forma giuridica e ruolo del Collegio Sindacale" - curato dalla Fondazione Aristeia e dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti - come termine di paragone nazionale (per brevità indicheremo come indagine Aristeia) e del database AIDA (Analisi Informatizzata delle Aziende) del Bureau van Dijk, per i dati delle aziende calabresi . Manca uno studio sulle cause delle crisi aziendali nel Mezzogiorno, che tenga anche conto dei possibili anticipatori del default: protesti, incagli e sofferenze, decreti ingiuntivi, eccedenze, iscrizioni e cancellazioni nel registro delle imprese. I dati presentati sono fermi al 2001, perchè mancano indagini più aggiornate, ma sono tuttavia utili per cercare di avere una valutazione del fenomeno.
In Italia vi sono circa sei milioni di imprese, il 61% delle quali (oltre tre milioni e mezzo) sono ditte individuali; nella figura 1 si è riportata la composizione percentuale ripresa dall'indagine Aristeia. Se si eccettuano le ditte individuali, che sono imprese familiari, si può semplificare dicendo che l'universo societario (due milioni e 300 mila società in Italia) si divide equamente in terzi: un terzo società a responsabilità limitata, poco meno di un terzo società in nome collettivo ed un terzo in altre forme societarie. Le società per azioni sono una piccola minoranza (due e mezzo per cento). A prescindere dal numero, le spa restano comunque le organizzazioni imprenditoriali più importanti sia in termini di volume di fatturato che di occupazione, l'aggregato comprende tutte le realtà aziendali più significative. Il campione AIDA è costituito, invece, da oltre 170.000 società che hanno presentato i propri bilanci presso il Registro delle Imprese, ruolo oggi delegato alle Camere di Commercio, ed è pertanto molto significativo poichè include le società attive. Per la Calabria il campione è composto da due mila società.
Rispetto all'indagine Aristeia emergono significative differenze: le srl sono i due terzi del totale, le società per azioni salgono al 17% e le snc diventano un numero esiguo: insieme a tutte le altre forme societarie non si supera il 6% del totale. Questo perché ditte individuali e società di persone non presentano bilanci al Registro delle Imprese, salvo qualche caso particolare. Il campione AIDA fornisce una rappresentazione più realistica della situazione imprenditoriale italiana interessata alle procedure concorsuali. Una volta tanto la regione non si colloca con sicurezza all'ultimo posto. Per numero di società per azioni, infatti, la Calabria è penultima in Italia, precedendo la Puglia (il 7.3% del totale rispetto al 5,8% della Puglia; nelle regioni più evolute, tuttavia, il rapporto supera il 20%).
| Regione | S.P.A. | S.R.L. | S.N.C. | Altre | Totale |
| Abruzzo | 10,6 | 82,6 | 0,4 | 6,4 | 100,0 |
| Valle d'Aosta | 22,1 | 71,6 | 0,0 | 6,2 | 100,0 |
| Basilicata | 11,0 | 80,9 | 0,2 | 8,0 | 100,0 |
| Calabria | 7,3 | 87,4 | 0,3 | 4,9 | 100,0 |
| Campania | 10,9 | 83,8 | 0,2 | 5,1 | 100,0 |
| Emilia-Romagna | 15,7 | 76,7 | 0,4 | 7,2 | 100,0 |
| Friuli | 19,3 | 75,4 | 0,4 | 4,9 | 100,0 |
| Lazio | 12,0 | 80,7 | 0,1 | 7,2 | 100,0 |
| Liguria | 18,1 | 76,7 | 0,2 | 5,0 | 100,0 |
| Lombardia | 21,7 | 74,5 | 0,3 | 3,5 | 100,0 |
| Marche | 12,1 | 81,8 | 0,5 | 5,6 | 100,0 |
| Molise | 15,0 | 76,0 | 0,3 | 8,8 | 100,0 |
| Piemonte | 21,5 | 73,3 | 0,5 | 4,7 | 100,0 |
| Puglia | 5,8 | 88,5 | 0,2 | 5,4 | 100,0 |
| Sardegna | 11,5 | 81,2 | 0,2 | 7,1 | 100,0 |
| Sicilia | 12,0 | 79,7 | 0,2 | 8,1 | 100,0 |
| Toscana | 14,8 | 79,9 | 0,3 | 4,9 | 100,0 |
| Trentino-Alto Adige | 17,4 | 71,6 | 0,6 | 10,5 | 100,0 |
| Umbria | 13,3 | 79,8 | 0,2 | 6,7 | 100,0 |
| Veneto | 17,7 | 77,2 | 0,5 | 4,6 | 100,0 |
| n.a. | 0,0 | 28,6 | 0,0 | 71,4 | 100,0 |
| Totale | 16,7 | 77,7 | 0,3 | 5,3 | 100,0 |
Mentre le società di capitali sono sempre fallibili, per l'imprenditore che opera come ditta individuale o anche come società di persona, la fallibilità è legata alla definizione di piccola impresa, di artigiano e di imprenditore agricolo. Questi ultimi vengono esclusi dalle procedure concorsuali.
Non esiste nel nostro codice una precisa definizione che consenta di tracciare un confine netto tra l'imprenditore fallibile ed il piccolo imprenditore. Nel concreto si fa ricorso ad un criterio geografico, coniugando la definizione con la realtà economico-sociale con il reddito dell'attività e mettendola a confronto con quello dei lavoratori dipendenti nel medesimo settore. Quando l'attività imprenditoriale consente di godere di un tenore di vita superiore alla classe apicale del lavoro dipendente, egli viene considerato fallibile. È certamente un criterio molto opinabile, poichè nel momento della crisi aziendali, i redditi sono molto bassi o inesistenti. Si cerca tuttavia di rispondere con criteri di sano realismo alla mancanza di una definizione legislativa più precisa.
Nella personalizzazione del criterio, si attua una politica che varia nei distretti giudiziari della Regione, creando delle disparità di trattamento molto accentuate nel recente passato, ma che fortunatamente vanno attenuandosi. Qualora si volesse far ricorso a parametri più obiettivi - come la definizione di piccola impresa dettata dall'Unione Europea o seguendo il criterio stabilito per la nomina del collegio sindacale nelle società di capitale - le sezioni fallimentari dei nostri Tribunali dovrebbero ... dichiarare fallimento, per assenza di materia prima. La realtà produttiva calabrese si dimostra molto fragile ed ha bisogno di una cura personalizzata in ogni settore. La frattura tra le due aree del Paese è evidente in sotto molto profili, e questo è un esempio evidente.
È incoraggiante costatare che i tempi di definizione dei fallimenti si sono notevolmente accorciati negli ultimi anni, con sensibili miglioramenti nella tutela degli interessi dei creditori. Tradizionalmente, i costi della procedure finivano per assorbire una parte cospicua dell'attivo fallimentare, con la conseguenza che lo scopo ultimo sembrava essere il mantenimento dell'apparato burocratico, dal curatore al giudice, piuttosto che la tutela degli interessi dei creditori dell'asse fallimentare.
La Legge 89/01 c.d. legge Pinto, in vigore dall' aprile 2001 ha finalmente introdotto anche nel nostro ordinamento il principio dell'equo processo, stabilito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Viene demandando alla Corte d'Appello il compito di stabilire, con sentenza immediatamente esecutiva, un indennizzo per lesione del diritto di ogni cittadino ad ottenere una sentenza in termini ragionevoli. È da segnalare che a Cosenza un giovane e brillante magistrato ha fatto affiggere nei locali del Tribunale un foglio contenente un preciso richiamo a questa nuova normativa per ricordare a tutti gli attori del processo che devono concorrere al rispetto della norma, evitando inutili espedienti dilatori.
'A Curti è longa longa. La lentezza della Giustizia è sempre stata proverbiale. Oggi vi è la concreta speranza che fra i tanti primati negativi della regione, non vi sarà più la lunghezza dei processi. Per fare un confronto, la durata media dei procedimenti concorsuali in Italia è di circa 9-10 anni: in Calabria tale termine si dimezza ed è un miracolo, che trova una parziale giustificazione nella minore complessità delle condizioni aziendali e nella scarsa consistenza degli attivi fallimentari. Non si può non segnalare però che in questo comparto la presenza di magistrati giovani e motivati è riuscito a smuovere un acquitrino stagnante da tempo immemorabile.
I risultati più significativi dell'indagine Aristeia evidenziano una sensibile riduzione del numero dei fallimenti Italia nel quadriennio considerato (1998-2001), con una consistente differenza in favore delle società che hanno un Collegio Sindacale. La presenza dell'organo di tutela sembra favorire un più alto tasso di sopravvivenza delle aziende, che sembrano avere anche una migliore organizzazione aziendale.
Per la Calabria non abbiamo elementi quantitativi e dobbiamo fare ricorso a metodi nasometrici, basati su informazioni confidenziali degli addetti ai lavori. Si possono trarre alcune conclusioni. In primo luogo, vi è una quasi completa confusione tra imprenditore e impresa, a prescindere della forma giuridica: anche le società sono in fondo delle ditte individuali, poichè i soci sono legati da stretti vincoli di parentela (marito e moglie, padre e figlio ecc.). Nella stragrande maggioranza dei casi, una società di capitali in Calabria è una ditta individuale esercitata sotto forma giuridica diversa per molteplici ragioni, soprattutto di natura fiscale. Rarissimi sonno i casi reali di una volontà cooperativa tra soggetti diversi, di mettere insieme la loro esperienze, lavoro e capitale, kow-how e patrimonio, organizzazione commerciale e capacità produttiva.
Il ciclo di vita aziendale è strettamente connesso a quello dell'imprenditore. Superati i 30-40 anni dalla fondazione si cominciano a manifestare inequivocabili segni di decadenza, per il declino fisico del fondatore. La successione risulta difficile e problematica, poichè l'organizzazione aziendale è carente e non consente una formazione manageriale, ma l'arte va appresa con un lungo apprendistato, al quale solo in pochi vogliono sottoporsi. A volte la stessa istruzione universitaria, orgoglio del genitore-imprenditore ed esibita con spavalderia dai figli, finisce per rappresentare un ostacolo. Il desiderio di applicare le tecniche più avanzate apprese negli atenei in realtà molto fragili è spesso un esercizio teorico portato avanti con pressappochismo e può rappresentare un pericolo per la sopravvivenza stessa dell'azienda. L'urgenza ed inderogabilità di un ammodernamento dell'apparato produttivo deve procedere con una forzata gradualità senza stravolgimenti.
I fallimenti in Calabria sono concentrati in tre settori: abbigliamento e calzature, commercio alimentare e imprenditoria edile. Questo trova una spiegazione nel numero di aziende dei settori interessati che costituiscono la stragrande maggioranza del totale delle aziende, e nella grande rivoluzione che ha interessato ciascuno di essi.
L'abbigliamento e le calzature hanno visto un impressionante aumento della presenza dei "cinesi" che hanno introdotti articoli a basso prezzo, spesso imitazioni o contraffazioni di marchi più prestigiosi. Sono settori economici maturi dove la concorrenza dei Paesi BRIC (Brasile, Russia, India e Cina, le nuove aggressive tigri economiche del mondo) sarà sempre più feroce e le crisi delle aziende del settore sono destinate ad aumentare.
Il comparto elementare ha visto la nascita di supermarket, di centri commerciali e di hard discount, punti vendita sempre più grandi e competitivi, in grado di offrire una vasta gamma di beni, che per un piccolo negozio di vicinato sarebbe troppo costoso garantire. Il settore del piccolo commercio è investito di una crisi irreversibile, che avrebbe forse bisogno di qualche forma di intervento pubblico per evitare un depauperamento dei centri storici più significativi.
L'attività edilizia è andata evolvendosi con altrettanta rapidità. Si va diffondendo un maggior tasso di legalità e minore improvvisazione, a dispetto dei condoni che tendono a perpetuare comportamenti illeciti. È tramontata l'epoca del fai-da-té, le nuove costruzioni vanno concentrandosi nei centri abitati di maggiore dimensione (Cosenza-Rende, Corigliano-Rossano, e così via) per la sempre maggiore richiesta di servizi e di qualità residenziali più moderne. Vi è meno spontaneismo e maggiore richiesta di professionalità nel comparto, quindi. A questo deve aggiungersi l'effetto delle agevolazioni edilizie che richiedono l'esibizione di idonea documentazione tecnica e fiscale, il maggior ricorso ai mutui bancari e la legislazione comunitari sulla sicurezza degli impianti. L'attività edile non può essere più improvvisata e molti pagano l'inesperienza con il trauma del fallimento. È tuttora significativo il numero di default nel settore edilizio legato alla trasformazione in impresa di ex-manovali, che riuscivano a gestire una condizione di precarietà, ma non sono in grado di rispondere alle sollecitazioni delle nuove norme.
Al di fuori di questi settori tradizionali, dopo anni di piatta normalità con fallimenti di attività molto marginali, la Calabria ha fatto registrare nell'ultimo biennio un consistente aumento di crisi aziendali significative, imprese con un numero di dipendenti compreso tra gli 8-10 in su, che per la nostra regione sono già considerevoli. Le ragioni di un fallimento sono sempre molto peculiari ed è difficile trovare un comune denominatore. Tuttavia, quando si verifica una concentrazione statisticamente rilevabile è sempre frutto di fattori extra-aziendali. Nel caso specifico, sono venute a maturazione situazioni di crisi frutto del ciclo negativo iniziato nel 1992.
L'esperienza empirica delle società commerciali calabresi non sembra affatto confermare il ruolo positivo del collegio sindacale nel prevenire ed evitare la crisi d’impresa. La sua presenza è solo in ossequio ad un adempimento giuridico formale, ma non gli viene riconosciuta alcuna funzione significativa dall'imprenditore: tutt'al più viene considerato uno strumento per adempiere qualche abbricazione, di fare cioè un piacere a professionisti amici. Il suo ruolo di controllore e di consulenza sembra nullo, e il Collegio si configura unicamente come un inutile appesantimento di costi. Non si registrano, infatti, significativi interventi di tutela a favore della società.
I dati Infocamere sull'iscrizione e cancellazione del numero delle imprese in Calabria, mostra ancora un trend positivo, sebbene meno vivace che negli anni precedenti. Come detto, negli ultimi due anni si sono manifestate crisi che si possono considerare importanti se riferite al contesto economico-sociale. Si possono menzionare nomi ben conosciuti nella realtà economica locale, come Corvasce, il Calzaturificio di Luzzi, la DNE, la MdC (Manifatture del Crati), il Pastificio Lecce e così via che hanno grandemente indebolito il già fragile tessuto imprenditoriale locale. Uno degli aspetti più negativi è costituito dall'assenza di un cordone sanitario, di monatti che accorrono in soccorso delle aziende in difficoltà, anche nel caso vi siano degli asset sicuramente di successo, come il marchio Cesare Firrao, conosciuto in tutto il mondo. Non vi sono stati imprenditori locali che abbiano avanzato richiesta di continuare l'attività produttiva, che si potrebbe avvalere di impianti perfettamente funzionanti rinnovati recentemente con le agevolazioni della Legge 488 e di maestranze addestrate a produrre articoli di grande qualità.
Vi è stato, nel caso del Calzaturificio di Luzzi, l'interessamento di soggetti provenienti dall'esterno. Ma il loro interesse si limitava al marchio, al nome, senza alcuna proposta volta ad utilizzare impianti e know-how locali. Si voleva soltanto trasferire altrove la produzione e cercare di far vivere nella memoria un pezzo di storia industriale della Calabria, senza alcun impatto occupazionale. Non dissimile il discorso del Pastificio Lecce, meno glorioso come marchio, ma tuttavia interessante in un momento di riscoperta della grande cucina mediterranea e dei suoi prodotti: una buona campagna pubblicitaria avrebbe sicuramente potuto dare ottimi frutti per tentare una conquista del mercato regionale, caratterizzato da una subalternità ed una dipendenza dall'esterno in tutti i settori, compresi quelli agro-alimentari che dovrebbero essere la vocazione naturale del territorio.
Il ruolo degli incentivi ed il loro influsso nel destino aziendale meriterebbe un esame approfondito. Tanto nel caso del Pastificio Lecce che nel Calzaturificio di Luzzi, ad esempio, con le agevolazioni del Mezzogiorno si è attuato un piano di investimento faraonico, realizzando impianti tecnologicamente molto avanzati ed una capacità produttiva ridondante rispetto alla penetrazione sul mercato. I grandi investimenti non hanno impedito la crisi aziendale, anzi hanno contribuito ad acuirla, poichè hanno posto drammaticamente il problema commerciale e la conseguenza di dover affrontare una concorrenza sempre più agguerrita. Un altro dei peccati mortali è quello di voler tentare a tutti i costi di annullare la quota di finanziamento a carico con una serie di espedienti più o meno leciti. Si costruisce un complicato cubo di Kubrik che appesantisce finanziariamente la gestione. L'imprenditore si ritrova vittima di una complicata costruzione di scatole cinesi che funzionano fin quando si riesce ad averne un completo dominio. Quando il meccanismo s'inceppa, il castello costruito rovina sul loro stesso artefice, travolgendolo col il loro insopportabile peso.
Nella concreta esperienza delle Sezioni fallimentari dei Tribunali calabresi uno dei casi più frequenti è proprio quello delle aziende che falliscono nel tentativo di realizzare investimenti agevolati. Gli aiuti si trasformano spesso in una spinta al fallimento, e questo non avviene solo quando si attua un tentativo di distrazione di fondi.
Le cause più frequenti di fallimento delle imprese calabresi sono legate all'inesperienza ed all'improvvisazione. Il numero maggiore si concentra, come si è visto, in settori che presentano una scarsa specializzazione e sono caratterizzati da un alto indice di mobilità. Nonostante i fallimenti, la scarsa specializzazione le fa oggetto di sperimentazione e si continuano a creare aziende molto deboli, incapaci di reggere il peso della concorrenza. Esse si eliminano da sole per l'accanita guerra civile tra poveri. Spesso questa selva di aziende non riesce a garantire una qualità adeguata e soprattutto un'assistenza post-vendita. Trattasi nella maggior parte dei casi di imprese che non danno alcuna garanzia di continuità.
Un aspetto interessante è la scarsa incidenza della malavita organizzata nel fenomeno dei fallimenti nella Regione. La 'ndrangheta sembra sia diventata la mafia più potente ed organizzata e la criminalità economica è certamente strettamente collegata con essa, ma il fenomeno non emerge in sede fallimentare. In parte è un fenomeno fisiologico poichè nelle procedure concorsuali non si affrontano reati penali, al di fuori di quelli contemplati dalla legislazione economica (bancarotta fraudolenta, distrazione di fondi ecc.).